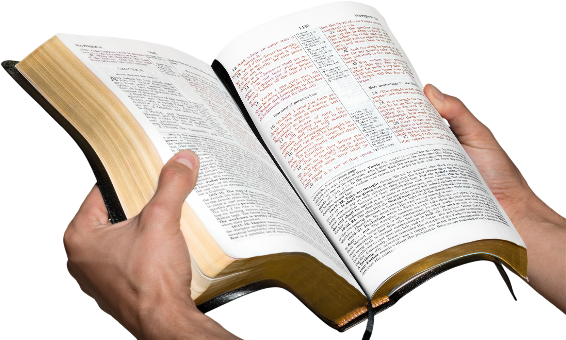88.147.12.100
Stazioni Quaresimali 2025 / II
14 marzo 2025 – Parrocchia La Salette Olbia
Quello di Luca è il vangelo che leggiamo nelle domeniche di quest’anno.
Quanto dirò questa sera lo traggo dagli appunti di una riflessione del biblista francescano Giulio Michelini tenuta ad Arezzo nel dicembre del 2020 e vorrebbe semplicemente evidenziare alcune particolarità del racconto della Passione che ci ha tramandato il vangelo di Luca.
La passione di Gesù secondo Luca[1]
- Rileggere i racconti della passione e risurrezione di Gesù secondo Luca significa andare al cuore dell’annuncio cristiano, perché l’annuncio del Vangelo – il cosiddetto kerigma – parte proprio da questi eventi e dalla fede che hanno suscitato.
La Chiesa contemplerà questo mistero nella prossima Settimana santa, l’unica volta dell’anno in cui leggerà integralmente, due volte, il racconto della passione e morte di Gesù, rimandando invece l’annuncio della risurrezione alla domenica di Pasqua.
Con il racconto della passione e morte non è possibile la lettura liturgica a “pezzettini” o, in termini tecnici, a “pericopi” come facciamo abitualmente con le altri parti del vangelo. La Chiesa infatti ha capito che quel racconto non poteva essere frammentato, anche se un’eccezione c’è, ed è il racconto della Cena del Signore che facciamo in ogni eucaristia.
Non intendo parlarvi della questione della formazione dei vangeli, ricordo solo che, probabilmente, esisteva un racconto della passione di Gesù prima della stesura dei nostri Vangeli sinottici. Il racconto di Luca potrebbe aver avuto come fonte non solo Marco, ma anche una tradizione indipendente degli altri vangeli, che avrebbe permesso all’evangelista di aggiungere alcuni dettagli che solo questi ci fornisce.
Uno su tutti: una terza fase del processo a Gesù, quella davanti a Erode Antipa. Ma sono molti di più gli elementi esclusivamente lucani, descritti bene da Gérard Rossé (Il Vangelo di Luca, p. 825): omissioni (unzione di Betania, ad es.) o spostamenti (come il silenzio di Gesù, di cui diremo); ordine dei fatti; episodi propri: parole di Gesù all’ultima cena, angelo consolatore al Getsemani, comparizione davanti ad Erode, lamento delle pie donne, dialogo con i due ladroni, le parole di perdono del crocifisso. Luca ha anche a disposizione informazioni proprie, come il soggiorno notturno di Gesù presso la casa del sommo sacerdote (22,54: «Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote»).
- L’inizio del racconto della passione in Luca lo troviamo all’inizio del cap. 22,1-2: «Si avvicinava la festa degli Azzimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo» e Satana entra in Giuda (22,3; cf. Gv 13,27). Questo è dunque il preludio della passione che parte dall’organizzazione del Pesah, da quanto detto su Giuda e dal complotto per mettere a morte Gesù. È una scena d’apertura che ha lo scopo di inserire il lettore nel racconto della passione.
Dal v. 7 si tratta della cena pasquale, cena che in Luca ha alcune caratteristiche proprie. Eccone alcune:
- La dichiarazione sul banchetto del Regno che luca pone prima della condivisione del pane: «17E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi, 18perchè io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio» vv. 17-18.
- I due calici (o coppe): la prima al v. 17, la seconda al v. 20.
- La “nuova alleanza” e non nel sangue ma nella coppa (v. 20)
- La disputa su chi è il più grande.
In questo incontro prenderemo in esame solo quegli aspetti di Luca che ne caratterizzano il racconto.
- La cena
La parte propria di Luca è quella che con Carlo Broccardo possiamo chiamare un “discorso di addio” aggiunto dall’evangelista, o un “testamento spirituale” che prende l’avvio da una discussione su chi fosse il più grande. In definitiva, si può parlare qui di una cena che, rispetto agli altri vangeli sinottici, assume maggiormente il carattere di un simposio greco.
Rileggiamo la questione della discussione, Lc 22,24-27:
«24E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerarsi più grande. 25Egli disse: “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. 26Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. 27Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».
Luca ripropone a questo punto una discussione già presente al cap. 9, poco prima dell’inizio del viaggio verso Gerusalemme, 9, 46-48:
«Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: “Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è più piccolo fra tutti voi, questi è grande».
La stessa questione invece nei vangeli di Marco e Matteo si trova dopo il terzo annuncio della passione di Gesù, con una argomentazione più simile a quella che troviamo in Luca nel racconto della passione.
Matteo Crimella osserva che «nel momento dell’annuncio della morte prossima e del tradimento da parte di uno dei discepoli, la disputa di questi ultimi sul più grande è particolarmente incongrua. Era già sorta in precedenza, ma il suo riapparire alla cena mostra che è un problema sentito dagli apostoli e un’importante questione della Chiesa, una questione che deve essere trattata effettivamente alla luce della morte di Gesù» (M. Crimella, Luca, p. 333).
- Passiamo ora al secondo quadro, proprio di Luca, sul quale ci soffermiamo, ovvero la preghiera e la lotta di Gesù nel Getzemani.
La pericope lucana riguardante la preghiera di Gesù sul Getsemani si distingue dalle altre versioni per diverse ragioni. Eccone il testo.
«39Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”. 41Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42”Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 43Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 46E disse loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”».
Questa pericope deve essere letta però a partire da quanto Luca scrive prima, e che ancora caratterizza il suo racconto della cena, ovvero la discussione sulle spade: Lc 22, 35-38:
«35Poi disse loro: “Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?”. Risposero: “Nulla”. 36Ed egli soggiunse: “Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 37Perché io vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento”. 38Ed essi dissero: “Signore, ecco qui due spade”. Ma egli disse: “Basta!”».
Tante sono le domande suscitate da questo testo, tra le quali emergono il perché del fraintendimento dei discepoli: di quale spada sta parlando Gesù (in senso metaforico), e cosa comprendono i discepoli? E da dove provengono le due spade che i discepoli hanno con sé? Erano per l’agnello pasquale?
Il Gesù di Luca, in ogni caso, affronta la lotta nell’orto degli Ulivi subito dopo aver respinto (22,38) le due spade che i discepoli gli propongono di usare, e subito prima che questa proposta venga comunque messa in atto dai discepoli (22,49: «Dobbiamo colpire con spada?»), e ancora una volta respinta da Gesù (22,51).
Se invece si tengono insieme questi passaggi, diventa evidente che anche la lotta di Gesù sul Monte degli Ulivi ha a che fare anche con la duplice provocazione che gli viene dai suoi discepoli. È perciò importante collocare la scena dell’agonia di Gesù nel co-testo di quanto è narrato prima e dopo: la coesione di queste pagine è data non tanto dall’unità di luogo che cambia, quanto dalla semantica dei termini usati (spada, lotta, sangue).
Ma in questo campo semantico della lotta un ruolo particolare viene svolto dall’angelo che compare in Lc 22,43. Una delle funzioni principali esercitate dagli angeli nei racconti evangelici sembra essere quella di interpretare, di dare il senso, di quanto accade. Ma in questo caso non si tratta di questo perché Gesù ha già compreso il senso di quanto accade. Si potrebbe trovare un legame più stringente con gli angeli che compaiono nei vangeli di Marco (1,13) e Matteo (4,11) al momento della grande prova di Gesù, al termine delle tentazioni nel deserto. Tante sono le interpretazioni proposte dagli autori. Giulio Menchini accoglie quella che vuol vedere il testo dell’agonia nel Getsemani in rapporto all’episodio della lotta di Giacobbe con l’angelo nel fiume Iabbok (Gen 32,23-33). Non si tratterebbe dunque di un angelo che “conforta”, ma che lotta con il Cristo. Dietro il quale potrebbe esserci l’immagine dell’Impero Romano, ma non solo Luca potrebbe aver voluto trasportare questa lotta a un livello più altro, si tratterebbe di una lotta cosmica tipo quelle che incontriamo nel libro dell’Apocalisse.
- Il processo di Gesù secondo Luca
Luca riferisce una notizia importante circa il processo di Gesù. Non si limita alla narrazione di quanto accade nell’improvvisato sinedrio, e nemmeno all’interrogatorio di Pilato, ma conosce il fatto che Gesù venga mandato da Erode. Erode Antipa era il figlio di Erode il Grande, ed era divenuto tetrarca della Galilea alla morte del Padre. Il titolo implicava che egli non era “re”, come il padre, ma “governatore della quarta parte” del suo regno (che era stato diverso tra questi, Archelao e Filippo), e corrispondeva al titolo di principe. Sia Pilato, che normalmente risiedeva a Cesarea Marittima, sia Erode, che normalmente risiedeva a Tiberiade, si trovavano a Gerusalemme per la Pasqua.
Pilato manda Gesù da Erode, perché avrebbe avuto giurisdizione su di lui, se fosse stato nella sua regione.
Alcuni elementi teologici da sottolineare:
Al v. 28: Erode è contento di vedere Gesù, e il lettore viene quindi portato a ricordare quanto già sapeva su di lui:
In Lc 3,18-19, si racconta dell’arresto di Giovanni da parte di Erode, a causa di Erodiade.
In Lc 13, 32-33 è Gesù a parlare di Erode, che viene descritto nel seguente modo: «31In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: “Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere”. 32Egli rispose loro: “Andate a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio demòni e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 33Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”».
Il secondo dettaglio che ci interessa è il silenzio di Gesù davanti a Erode. Secondo alcuni, potrebbe essere che Luca intenda rappresentare il Messia come il Servo sofferente che si legge in Is 53,7 dove si legge: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca».
Michelini offre un’altra interpretazione, centrata sul silenzio di Gesù come modo per creare l’ascolto ed estrema modalità di comunicazione. I vangeli di Matteo e di Marco sono concordi nel constatare il silenzio di Gesù davanti all’improvvisato sinedrio, quando non risponde alla domanda del Sommo sacerdote: questi gli chiede: «Non rispondi nulla?» (Mt 26,62; Mc 14,60) o, secondo Marco, «taceva e non rispondeva nulla» (Mc 14,61). Solo alla fine, quando la domanda del processo si concentra sulla messianicità di Gesù, allora questi risponde. Nel Terzo vangelo viene sciolto il mistero di questo silenzio di Gesù, quando Luca osserva – solo lui – che alla domanda «Sei tu il Cristo?», Gesù risponderà: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete» (Lc 22, 67-68). Il silenzio nei vangeli di Matteo e Marco viene dunque esplicitato da Luca: anche in questo caso, come davanti ad altri avversari, Gesù saprebbe rispondere, ma non lo fa perché sa bene che le sue parole non verrebbero comunque ascoltate o credute.
Nel prosieguo del processo, ovvero nella seconda fase, quella dell’interrogatorio di fronte al prefetto di Roma, il silenzio di Gesù è ancora più evidente e viene segnalato appositamente da Matteo (27,14) e Marco (15,4). Luca invece sposta quel silenzio nel “non dialogo” con Erode Antipa, una situazione di cui solo Luca è al corrente. Se Erode si rallegra perché può finalmente vedere Gesù, e lo interroga con molte domande, Gesù non gli risponde nulla (Lc 23,9), suscitando la sua ira.
Si noti che diversamente da Marco e Matteo, Luca non riferisce dello scherno che i soldati romani compiono contro Gesù, alla fine dell’interrogatorio di Pilato. Sono invece i soldati di Erode a insultarlo e a sbeffeggiarlo di lui: «Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò da Pilato».
Tornando al silenzio di Gesù davanti alle autorità, questo è paradossale da più punti di vista. Gesù aveva esortato i suoi discepoli a confidare nell’aiuto dello Spirito, quando si fossero trovati perseguitati, perché lui avrebbe mostrato loro ciò che avrebbero dovuto dire (cf. Mt 10,19), qui Gesù non rispetta quanto ha chiesto agli altri di fare. Ma la causa del suo silenzio non consiste nel fatto che si sta “avvalendo della facoltà di non rispondere”. Ma che sta proprio rispondendo col suo silenzio.
Non si tratta di una resa, quanto piuttosto dell’unico e ultimo modo con cui si può dire qualcosa: in questo caso, il silenzio è davvero assordante. Paradossalmente, è il modo in cui è solo possibile, da parte degli antagonisti, l’ascolto.
Il Logos in alcune situazioni non parla. Se però sta in silenzio, sarà Dio Padre, alla fine dell’esperienza terrena del Messia, a colmare questo silenzio, con la sua potente voce, ad esempio con il segno epifanico del terremoto in Matteo. Nel silenzio su Gesù o di Gesù è dinque nascosta, ma pur sempre efficace, una comunicazione di Dio, la Parola del Padre, ma anche l’unico modo che Gesù ha davanti ai suoi avversari: anche se l’avesse detto, non avrebbero creduto. Questo silenzio non lo salverà comunque dalla morte.
- «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno»
Leggiamo ora i due versetti che descrivono la crocifissione di Gesù, e le sue prime parole in croce, secondo Luca:
«33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 34Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte» (23,33-34).
Il v. 33 trova riscontro anche negli altri vangeli, ma non il v. 34. Si tratta del perdono di Gesù dato alla sua morte. Una prima questione che è stata sollevata riguarda per chi stia pregando Gesù: per i soldati romani, che materialmente lo stanno crocifiggendo? O per gli ebrei? I Romani non sono chiamati in causa in questa pericope, e quindi il riferimento deve essere agli Ebrei. E l’ignoranza di cui parla Gesù in cosa consiste? Non in una mancanza di conoscenza, quanto piuttosto in un giudizio erroneo su Gesù, che infatti viene chiamato “innocente” dalla moglie di Pilato, nel vangelo secondo Matteo (27,19).
Il v. 34 però non è attestato in modo sicuro nella tradizione manoscritta, ed è ritenuto incerto dalle edizioni critiche moderne del Nuovo Testamento: si tratta di uno dei problemi testuali più importanti del vangelo secondo Luca. È assente nel Papiro 75 (III sec.) e nei principali codici (Vaticanus del IV sec. Come nel Bezae del V sec. e in diverse traduzioni antiche). Se per qualcuno l’assenza del versetto è difficilmente spiegabile come un modo da parte di qualche copista di togliere una frase imbarazzante dalla bocca di Gesù (la caduta di Gerusalemme era la prova che Dio non aveva perdonato gli Ebrei, e lasciarla poteva implicare che il Padre non avesse ascoltato la preghiera del Figlio), per altri invece le parole del v. 24 sono state eliminate per ragioni antigiudaiche (proprio la caduta di Gerusalemme del 70 era vista da molti come la punizione divina per la morte di Gesù, e questa interpretazione veniva rafforzata se le parole di Gesù venivano cancellate; cf. F. Bovon, Luke II, p. 307).
Le parole di Gesù sono comunque coerenti con il vangelo di Luca e l’opera lucana. Inoltre il v. 34 era noto ai primi padri, cioè Taziano, Ireneo ed Egesippo, intorno al 170-180, che lo citano. La sintonia con il linguaggio e la teologia dell’opera lucana sono evidenti ad es. nelle parole di Stefano, negli Atti degli apostoli, quando il martire perdona chi lo lapida (At 7, 59-60). Prima ancora Pietro aveva detto, nel suo discorso di Gerusalemme: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire» (At 3, 17-18).
Le parole di Gesù altro non sono che la conclusione di una vita giocata sul perdono. Gesù muore come aveva vissuto, insegnando il perdono, come aveva fatto nel Discorso della pianura, Lc 6,27-28: «amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male». Ma ora il perdono viene dato in modo radicalmente diverso rispetto al modello delle relazioni interpersonali: Gesù dona un perdono non richiesto, similmente a come lo aveva dato al paralitico, secondo il racconto di Mc 2, 1-12.
Commenta Paolo Sacchi (Storia del Secondo Tempio, pp. 469-470):
«Il Figlio dell’Uomo, secondo Gesù, aveva anche il potere, proprio perché giudice supremo, di perdonare i peccati […]. “Affinché voi sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere di perdonare i peccati, io ti dico – dice Gesù al paralitico – alzati e prendi il tuo letto” (Mc 2,12). Questo passo, che Marco pone non a caso all’inizio della predicazione di Gesù, contiene il nucleo di ogni speculazione cristiana successiva sulla giustificazione. L’idea di Gesù non è espressa in termini razionali, ma soggiace al suo gesto. E il Gesto di Gesù è di un radicalismo assoluto, in quanto agisce senza esserne stato richiesto. Non solo dà gratuitamente il perdono, ma lo dà addirittura a chi non lo ha chiesto».
Quello che in Marco si trova all’inizio del suo vangelo, si trova in Luca nelle parole del Messia dalla croce.
- o -
- I due ladroni
La scena della crocifissione e della morte. Gesù è inchiodato fra due ladroni (v. 33). Luca menziona gli attori: il popolo vede quanto accade, i capi lo scherniscono (v. 35), i soldati lo insultano (v. 36). Il cartello (v. 38) informa circa l’identità di Gesù. In poche righe risuona per ben tre volte l’insulto «Salva te stesso!»: prima in bocca ai capi, poi ai soldati, infine al malfattore appeso accanto a Gesù (v. 39). Intrecciate agli insulti vi sono tre parole di Gesù. La prima è una offerta di perdono: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (v. 34); la seconda parola è la risposta alla supplica del buon ladrone; la terza è la preghiera: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (v. 46).
Rispetto al parallelo di Marco, sua fonte, Luca inserisce un magnifico incontro che segna un processo di conversione e la relativa offerta di salvezza. Luca, geniale teologo, scriba mansuetudinis Christi (come l’ha definito san Girolamo), ci fa toccare la potenza del perdono ma soprattutto ci mostra che Gesù morente in croce dona salvezza. Dalla croce si sprigiona una potenza vivificante che già vince la morte.
Il primo malfattore prende la parola per insultare Gesù. Il suo è il grido della coscienza del peccatore incallito e impenitente, nel segno del sarcasmo ma pure della disperazione. Secondo lui se Gesù fosse veramente il Messia metterebbe in campo qualcosa per salvarsi e pure per salvare coloro che condividono il suo supplizio, magari anche con un bel colpo di scena. Il primo malfattore non coglie il singolare modo di essere Messia di Gesù: il mistero della regalità del crocifisso, la signoria del dolore innocente, il giusto sofferente, il Messia rifiutato dal proprio popolo, che tuttavia intercede e invoca perdono proprio per i suoi, rivelatisi nemici.
La domanda resta aperta: se Gesù è il Messia e il re dei Giudei perché non salva se stesso? Perché ha voluto realizzare una salvezza così? Perché la salvezza passa misteriosamente attraverso la croce? Perché la salvezza di tutti gli uomini, quella salvezza proclamata con forza dalla predicazione apostolica (Cfr. At 4,12: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati») viene da un uomo che non ha voluto o potuto salvarsi da solo?
C’è forse anche un riferimento alle tentazioni (4, 1-12). In quell’episodio si diceva che «il diavolo si allontanò per tornare nel tempo fissato» (4,13). Sulla croce Gesù è tentato, proprio intorno a ciò che sta realizzando, la salvezza. È tentato di realizzare una salvezza appariscente, visibile, stupefacente, senza condividere sino alla fine la morte e il peccato. Ecco l’ironia di Luca: mentre Gesù è schernito in realtà sta salvando l’umanità proprio condividendo l’impotenza, la debolezza, l’iniquità.
Tutto ciò rimanda, più in profondità, ad una parola difficile di Gesù: «Vi dico: deve compiersi in me questa parola della scrittura: “E fu annoverato tra i malfattori”» (22,37 che cita Is 53,12d). Questa misteriosa parola profetizzava la comunione di Gesù con i peccatori. La parola si realizza: Gesù è crocifisso fra i malfattori. E tuttavia la sua condivisione è segno di qualcosa di ben più profondo: il santo entra in comunione col peccato.
L’innocente è il Messia che dispone di sé e la cui potenza va oltre la morte in quanto invoca perdono per i suoi stessi uccisori. Gesù ha inaugurato il suo Regno e la venuta potente di questo stesso Regno inizia a manifestarsi appieno proprio dalla croce. Il legno dell’infamia diventa trono di misericordia: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!».
Dom Roberto Fornaciari
Vescovo di Tempio Ampurias
[1] Dagli appunti di un incontro di p. Giulio Michelini tenuto ad Arezzo nel dicembre 2020. Vedi anche G. Michelini, La lotta di Gesù sul Monte degli Ulivi e la resistenza antiromana. Interpretazione di Lc 22,39-46 tra narrazione e pragmatica, in Convivium Assisiense 2 (2016) 21-55.

 motivi: perché Dio lascia sempre la libertà di entrare nel suo amore o di rimanere nei propri atteggiamenti. Secondo: perché la parabola sta a noi viverla... Noi come la facciamo concludere? Ci lasciamo perdonare e abbracciare, riconciliare dal cuore del padre? Riusciamo a vivere una vera fraternità, un'accoglienza sincera e felice, entrando nella festa “del figlio che era perduto ed è stato ritrovato, che era morto ed è tornato in vita?” Il Signore ci manda sempre aiuti e segnali per comprendere perché e come tornare. Dobbiamo solo essere attenti...
motivi: perché Dio lascia sempre la libertà di entrare nel suo amore o di rimanere nei propri atteggiamenti. Secondo: perché la parabola sta a noi viverla... Noi come la facciamo concludere? Ci lasciamo perdonare e abbracciare, riconciliare dal cuore del padre? Riusciamo a vivere una vera fraternità, un'accoglienza sincera e felice, entrando nella festa “del figlio che era perduto ed è stato ritrovato, che era morto ed è tornato in vita?” Il Signore ci manda sempre aiuti e segnali per comprendere perché e come tornare. Dobbiamo solo essere attenti...